Simon Joyner si veste di candele da tè, di cuscini, d’una vecchia macchina da scrivere e trasporta i suoi suoni riflessivi e melodici, le sue morbide e accoglienti parole – accoglienti come può esserlo solamente il dolore – in un lunedì notte di metà Novembre, tra i colori soffusi del Godot Art Bistrot di Avellino.
Il suo ultimo disco, “Pocket Moon”, ha il sapore dolce di ciò che non c’è più, di ciò che proviene da un passato lontano e che si trasforma in un flusso emotivo che, almeno per quella che è la limitata durata d’un concerto, riesce a riempire il vuoto che il nostro presente, con le sue congetture forzate e le sue assillanti paure, scava nelle nostre piccole, affannose, inutilmente problematiche e, sempre più spesso, poco gentili esistenze.
Simon Joyner non scende a compromessi, non l’ha mai fatto, nella semplicità dei suoi suoni, nell’intensità delle sue parole c’è tutto il grigiore della nostra società, l’aria è pesante, quasi irrespirabile, non riusciamo più a pensare, non riusciamo più a sorridere. Che cosa n’è stato di quell’impeto emozionale e travolgente che, negli anni Novanta, sembrava dovesse rivoluzionare il nostro mondo, distruggere le vecchie ed obsolete trame che ci impedivano di essere noi stessi e proiettarci in un nuovo, pacifico, appagante millennio?
Oggi, che quel millennio lo stiamo vivendo, ci rendiamo perfettamente conto che è tutto rimasto com’era, anzi è peggiorato, perché la sfiducia nel prossimo, nel futuro, in noi stessi è la norma e le nostre giornate sono scandite soprattutto dal timore d’esser giudicati per quello che siamo. Ed allora la cosa più sensata che ci viene in mente è quella di piegarci, di conformarci al pensiero comune, coltivando e perseguendo sogni e stili di vita che non ci appartengono e che, alla lunga, ci rendono sempre più soli, sempre più fragili, sempre più volubili, sempre più vuoti. Indossiamo i nostri bei vestiti blu e ce ne andiamo in giro, con le nostre auto a rate, incapaci di provare empatia verso i nostri stessi simili, fingendoci occupati a costruire carriere che, in fondo, non faranno altro che avvelenarci e privarci sempre più della nostra stessa umanità.
È questo ciò che volevamo ottenere? Sentirci perennemente minacciati? Interpretare, a seconda del momento, personaggi diversi? Personaggi finti che non fanno che spingere sempre più giù, sempre più a fondo, ciò che siamo davvero? Ogni tanto ci farebbe bene fermarci e ricordare chi siamo, cosa vogliamo ottenere, dove ci piacerebbe vivere, con chi vorremmo stare. Esattamente come sta accadendo stasera, mentre sorseggiamo una birra bionda, ascoltando Simon Joyner mettere a nudo le sue emozioni più intime, cantando e raccontando di uomini e donne, di giovani e vecchi, di amici e sconosciuti che, esattamente come facciamo anche noi, cercano e perdono, trovano e vincono, ridono e piangono. Ma non importa, perché l’unica cosa che conta davvero è non fermarsi mai.






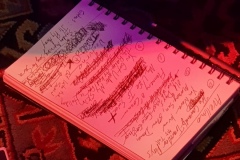


























Comments are closed.