1997, sarebbe davvero il caso di clonarlo questo anno, altro che la pecora Dolly. L’anno nel quale “Trainspotting” immortalava, a livello cinematografico, una generazione alla ricerca di sé stessa, mentre, nel frattempo, il mondo della musica più distante dai fenomeni mainstream iniziava a rendersi conto dell’invadenza esistenziale della nascente globalizzazione, grazie, soprattutto, a quel sovraccarico tecnologico che avrebbe, negli anni successivi, rapito, manipolato e schiavizzato le masse.
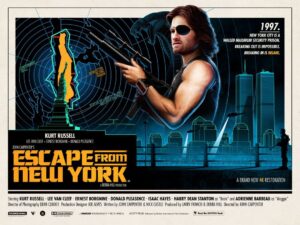 Il rock comprese pienamente che poteva essere anche altro e abbracciò, in maniera totale e appassionata, le tendenze e le influenze di stampo elettronico, neo-classico, avanguardistico e minimale del tempo, andando a scavare, sempre di più, nel mondo sotterraneo del pop lisergico, delle dissonanze rumoristiche e della bassa fedeltà. Certo, il passato acquista, dinanzi ai nostri occhi smarriti in questo grigio e bellicoso presente, un alone mitico e romantico, siamo portati ad idealizzarlo, a dimenticarne gli aspetti più ostili e negativi, lasciando che le nostre percezioni siano influenzate solo dalla nostalgia, ma è comunque importante e significativo soffermarsi su quello che di eccezionale venne pubblicato in quell’anno.
Il rock comprese pienamente che poteva essere anche altro e abbracciò, in maniera totale e appassionata, le tendenze e le influenze di stampo elettronico, neo-classico, avanguardistico e minimale del tempo, andando a scavare, sempre di più, nel mondo sotterraneo del pop lisergico, delle dissonanze rumoristiche e della bassa fedeltà. Certo, il passato acquista, dinanzi ai nostri occhi smarriti in questo grigio e bellicoso presente, un alone mitico e romantico, siamo portati ad idealizzarlo, a dimenticarne gli aspetti più ostili e negativi, lasciando che le nostre percezioni siano influenzate solo dalla nostalgia, ma è comunque importante e significativo soffermarsi su quello che di eccezionale venne pubblicato in quell’anno.
Ho scelto, quindi, alcuni di quei dischi, quelli che per me sono stati più significativi, ma è ovvio che ognuno può aggiungerne altri; non è assolutamente una gara, né una classifica, né una lista definitiva. Ciascuno può guardarsi indietro e scegliere di rivivere, riassaporare e riascoltare ciò che preferisce, in fondo è anche questo il bello di cercare nel tempo passato.
Partiamo, dunque, con le atmosfere rave e le sonorità drum ‘n’ bass dei Chemical Brothers di “Dig Your Own Hole”, un disco nel quale i fratelli chimici inglobavano, nei loro big-beat elettronici, atmosfere lisergiche e policromatiche tipiche degli anni Sessanta, influenzati sia dal recente movimento brit-pop, che dal loro vibrante e incalzante background elettro-funk di riferimento.
“Urban Hymns”, intanto, rappresentò il punto più alto del già citato brit-pop, ma anche il disco che ne decretò la fine, mettendo un punto al populismo reazionario e musicale che aveva preso piede in UK e mostrandoci come fosse possibile sopravvivere a quel mondo plastico e perfettamente beatlesiano. I Verve proposero, infatti, un percorso sghembo che sconfinava nelle tristi, cupe, mistiche e solitarie curvature cosmiche, in uno spazio sconosciuto che altri avrebbero amato, vissuto ed esplorato.
Ad iniziare dai Mogwai di “Young Team” che sbriciolarono e sminuzzarono ogni modello sonoro costituito da quei briosi ritornelli e da quelle narrazioni esistenziali di durata rigorosamente inferiore ai 3 minuti, riportando alla luce del sole del post-rock le leggendarie cavalcate elettriche intrise di rock sperimentale, rock d’avanguardia, rock psichedelico e rock robotico.
Perché, al di là delle più funeste previsioni riguardanti il millennium bug dell’atteso e imminente anno domini 2000, era evidente, invece, ai più attenti frequentatori della nascente rete delle informazioni, che i robot erano destinati a prendere il sopravvento e governare un mondo che, come descritto nel grandioso “OK Computer” dei Radiohead, sarebbe stato sempre più fluido, estraniante, paranoico e stressante, rendendoci, di conseguenza, più soli, più fragili e più angosciati, con lo sguardo fisso su delle luci al neon, le uniche amiche di una insonne nottata in giro per una città iper-tecnologica.
Un’oscurità dell’anima che si ritrova anche in Bjork, nel suo “Homogenic”, album ispirato da trame neo-classiche; questo lavoro ripercorre tutte le fasi di una malattia interiore, alla disperata ricerca di quella bellezza celestiale che è andata, purtroppo, perduta. Assenza, conflitto, perdita, sofferenza, sono queste le tematiche tra le quali si muove l’artista islandese, desiderosa di proporre sé stessa come cura salvifica, ma consapevole di essere pericolosa, tagliente ed affilata come una terribile lama.
Questa lettura drammatica del futuro dell’umanità riverbera anche tra le sonorità trip-hop dell’omonimo album dei Portishead, nel quale, però, ci sentiamo meno soli ed afflitti, perché dal remoto passato emergono spiriti ed ombre che, se da un lato possono spaventarci, dall’altro lato ci rammentano ciò che siamo stati, quello che abbiamo realizzato, i luoghi dai quali siamo partiti. Una serie di posti e di momenti che sono intrisi di dolci e suadenti trame jazzistiche, di pulsazioni dark ed ambient, di spettacolari tramonti western. Tesori inestimabili che nessun ipotetico futuro, per quanto dispotico, può portarci via.
E ripartiamo proprio da questi tesori, ripartiamo dalle epopee psych-jazz degli Spiritualized di “Ladies And Gentlemen We Are Floating In Space”, un viaggio shoegaze verso i confini di quella che è la nostra personale galassia emotiva, una galassia morbida ed avvolgente nella quale puoi incontrare ragazzi e ragazze che, come noi, cercano di scoprire i propri limiti espressivi, sentimentali e linguistici. Essenze che sono, finalmente, libere dagli abusi e dalle dipendenze che ci sconvolgono la vita. Liberi come lo sono i Depeche Mode di “Ultra”, una band capace di essere più forte di qualsiasi tortuoso percorso di riabilitazione fisica e mentale, perché la cosa più grave che può capitarci, nel 1997 come adesso, non è tanto sprofondare in un terreno tossico, ma non avere più la volontà di rialzarsi, di riconsiderare, in maniera critica e costruttiva, quelli che sono stati i nostri pensieri, le nostre scelte e le nostre singole azioni.



![1995-2025 The Bends, Radiohead [video]](https://www.paranoidpark.it/wp-content/uploads/2025/03/Radiohead-the-bends-140x90.jpg)



















Comments are closed.